
25 aprile 1945: Gnochi sbatùi
di
Piero Piazzola
Non sono ancora passati per me gli ottant’anni d’età, ma mi ci manca poco. Prendo a spunto il Nievo con le sue “Confessioni di un ottuagenario”; ma non pretendo assolutamente di paragonarmi a lui, nemmeno alla sua ombra, perché le “confessioni” che ho già fatto, le mie, e che farò più avanti, nei miei ricordi scritti, non sono vere e proprie confessioni; sono solamente considerazioni, riflessioni, desideri e bisogno di aprire qualche piega della mente e dell’anima, di scaricarne fuori le scorie che, altrimenti, potrebbero inceppare qualche ingranaggio interno, intimo, potrebbero nuocermi.
A quest’età vorrei solo fare alcune osservazioni, su un giorno in particolare, in senso più lato su quei giorni che seguirono e che ruotarono attorno a una data storica, ad un passaggio epocale -io lo considero epocale-, al ritorno alla vita. Una di queste riflessioni concerne un … simpatico compromesso che fa riferimento a quella giornata memorabile del 25 aprile. Qualcosa ho già scritto in merito anche in altre pagine.
Quel giorno, verso mezzodì, io con i miei compagni ... d’arme, ero di ritorno a Campofontana dalla Valle del Chiampo per un meritato (?) riposo che doveva preannunziare, chiamiamolo così, il congedo dalle … armi. La guerra era finita, le campane suonavano a stormo in tutti i campanili a cominciare da quello del mio paese per finire a tutti quelli che, dal piazzale della chiesa, spuntavano fuori, là, sui cocuzzoli dei monti d’intorno. Il suono di altre centinaia di campane ci giungeva anche dai campanili che non si potevano vedere o distinguere a causa dei rilievi montuosi che li sottraevano alla vista e altrettanto si dica da quelli del confinante Alto Vicentino; da questi ultimi, che non si vedevano, dato che spirava da mattina una leggera brezza primaverile, ugualmente si percepivano i suoni distinti e forti.
Campane a festa, a tutto volume, insieme a furiose raffiche di mitra e di mitragliatrici a salve, ultima eco di una guerra che stava chiudendo il sipario.
Adesso, quasi sessant’anni dopo, mi tormentano lo spirito certe scene simili a quelle di allora che vedo alla televisione: popoli del vicino oriente che “spediscono” al cielo interi caricatori di pallottole in segno di protesta o di festa, secondo le circostanze. A cosa serve tutto ciò? La morte è morte; la gioia è gioia. A cosa servirono i nostri spari di allora? Passato il frastuono, la sfrenatezza, buona e sincera fin che si vuole, rimanemmo ancora con le nostre ansie, con le nostre inquietudini. Con tutte.
Rientriamo nel tema. Festa anche in famiglia quel giorno. Ma quale famiglia! Io e mia mamma, due poveracci che l’avevano scampata per un pelo; si può chiamar famiglia questa? Eravamo ancora in casa dei Chini, per grazia di Dio, e per quel mezzodì mia mamma mi preparò nientemeno che il piatto più “succulento” che si potesse scegliere in un menu povero, di meschini, per un dì di festa: quello dei gnochi sbatùi o gnochi alla malghésa. Piatto semplicissimo: acqua, un uovo e farina bianca. Si fa un pastone piuttosto sodo, lo si scucchiaia a piccoli “bocconi” nell’acqua bollente salata — scrivo “bocconi” per far capire che poi, una volta cotti, questi bocconi dovevano poter passare, senza strangolarsi, tra la cerchia dei denti e la gola.
Poi, quando si sono rappresi e affiorano, si scolano e vi si versa sopra un po’ di burro di quello buono delle nostre malghe, fritto, quasi bruciato, un po’ di formaggio grattugiato e … una manciata di allegria che di solito si accompagna alla fame. Alla fame dei vent’anni!
La festa c’è stata ugualmente quel giorno. Ma quella volta di burro fritto, quasi bruciato neanche l’odore. Non ce n’era un grammo; l’avevano requisito, manco a dirlo, “le forze di occupazione”. Bisognava ricorrere ad un altro condimento: lardo, fritto anche quello, quasi bruciato; ma non lo consiglierei a nessuno per mangiare i gnochi sbatùi. È tutta un’altra cosa. Punto e basta!
La festa la facemmo ugualmente, io e mia mamma, quel mezzodì in casa mia. E fu un vero pranzo ... nuziale. La guerra era finita. Questo contava; e questo era il condimento più gradito, più stuzzicante. Ho scritto “nuziale”, perché in un certo senso eravamo riusciti a sposare di nuovo … la vita.
La vita quel giorno mi è parsa proprio più bella, più seducente ancora della più bella donna che io abbia mai visto. Io di belle donne ne ho viste pochine, ma non mi sono neppure preoccupato granché di vederne; ma mia moglie e qualche altra bella creatura femminile, che mi ha accompagnato lungo l’arco della mia carriera, quelle sì che le ho viste e sono state le più belle donne del mondo.
E
ci brindammo anche, sopra ai gnochi sbatti, quel giorno, con un paio di
bicchieri di … graspìa; un brindisi speciale, no? Un brindisi al “Buon Dio” che ci aveva
permesso di gettare l'ancora sulla riva del 25 aprile.
25 aprile: Festa della Liberazione! 18 anni. Sono passati quasi 60 anni. Oggi scrivo queste paio di righe che traggo da un mio curriculm vitae, ancora allo stato di manoscritto, per ricordare quel momento. Ma spesso mi domando: che cosa furono per me a quei tempi: la Liberazione, la Guerra partigiana, la Libertà, la Democrazia, l’Uguaglianza, i Diritti civili e via dicendo? Allora ne avevo capito qualcosa dello spirito, dei valori, degli ideali?
No! Purtroppo, no. Troppo giovane, troppo lontano dal grande mondo, dove di queste cose si parlava da tempo, troppo fuori della politica di allora.
Non sono il solo a dirlo. Mi viene in aiuto il prof. Francesco Guarienti, che nel 1994 ha rilasciato un’intervista al giornalista J. P. Jouvet: «Le confesso che non fu una scelta maturata attraverso riflessioni e convinzioni ideologico-politiche. Ero troppo giovane perché avessi già una coscienza profonda, radicata in questo senso, sebbene …». Una dichiarazione che condivido pienamente, perché anch’io mi sono trovato a riflettere sulle stesse cose. Poi la coscienza maturò; ma un anno di tempo e di riflessioni non potevano offrire un qualcosa di più appagante per organizzare convinzioni, per forgiare obiettività.
Nessuno parlava di politica al mio paese. Solo di guerra. Quei due, tre antifascisti che c’erano in paese e che potevano comunicare qualche considerazione, qualche indirizzo, magari a senso unico, tenevano le orecchie ben diritte. Tanto diritte che qualcuno, fascista dichiarato per i 25 anni precedenti, quando capì come si andava mettendo il conflitto, hinc et illico, corse a cambiar camicia. E nessuno fiatò. Io ero giovane e non m’interessavano i colori delle camicie; dovevo salvare la pelle; quella era la mia politica, la mia camicia da indossare il più presto possibile. E non mi vergogno di aver badato solo alla pelle, allora; e ho fatto di tutto per salvarla. Come ero in grado di fare, ovviamente; con tante contraddizioni interiori, con tanti punti interrogativi, con tanti “ma” e con tanti “se”; eppure con altrettanto spirito sincero e schietto.
Tutto il resto verrò a capirlo solo dopo, molto più tardi. Comincerò a capirlo, ma a livello istintivo, fondamentale, senza imbrogli e malizie, dopo le disavventure, dopo i giorni bui, dopo i guai che mi sono capitati e che, grazie a Dio, ho superato con un buon concorso di circostanze e con altrettanta buona stella. Ma della Resistenza, della Guerra di Liberazione, della Libertà, della Democrazia, ancora adesso, riferendomi a quei tempi, mi sforzo di racimolare i concetti scollegati di allora e, con altrettanta difficoltà, quelli più profondi che turbinavano nella mia testa. Piero Piazzola, alias “fulmine”.

Nella foto: L’autore, in tenuta paramilitare,
posa per una foto ricordo insieme a un compaesano.
Partigiani .... caduti dopo la liberazione
25 aprile! Giorno della liberazione. Lo festeggiammo anche noi, come da per tutto, col suono a distesa delle campane, con gli spari dei nostri mitra, con altre “scemenze” da ventenni che adesso mi fanno sorridere e anche un po’ arrossire. Ma era la fine della guerra e qualche stupidata si poteva anche commetterla. Troppa la contentezza! Eravamo ritornati proprio quel giorno al nostro paese da una missione nelle valli del Chiampo e dell’ Altissimo, finita bene per quasi tutti noi, non certo per Attilio che rimase ferito a un gamba e il Comando di Brigata aveva disposto che si tornasse a casa per qualche giorno di relax, in attesa di un richiamo per rientrare eventualmente in azione.
Non facemmo neppure in tempo a rimetterci in ordine, a misura d’uomo e a riordinare le idee, che improvvisamente arriva una disposizione perentoria da parte del Comando di Brigata di tornare immediatamente in quel di Arzignano, armati di tutto punto, e di dirigersi verso la località Guaina, suoi monti di Montorso. Partiamo, tutti e a piedi ovviamente — non avevamo mezzi di trasporto noi, poveri partigiani —, ci dirigiamo verso la zona di Montorso, non prima di esserci fermati un istante ad Arzignano dove il comando aveva organizzato la spedizione … punitiva. Cos’era successo?
Erano già trascorse quattro buone giornate dalla fine della cosiddetta “Guerra”, così almeno si diceva e così almeno credevamo e speravamo tutti.
Di guerra, invece, ce n’era ancora e per qualcuno di noi essa non terminerà più; per due nostri compagni non ci sarà più la Liberazione, non ci sarà mai la Pace, non ci sarà più il rientro in famiglia.
Alla Guaina c’era una bella villa, isolata, circondata da un terrapieno e da
una siepe. Là dentro un gruppo di “SS”, armati fino ai denti, con fucili di
precisione, decisi a vender cara la pelle, aveva stabilito provvisoriamente la
propria residenza senza il regolare permesso…dell’autorità. Ti viene da
ridere? Anche a noi sfuggì un sorrisino sotto i baffi, quel pomeriggio, perché
pensavamo che quei quattro disperati, a nostro parere, avevano sbagliato
indirizzo a insediarsi lassù, sulla dorsale di una montagna che non aveva
comunicazioni agevoli verso nord; perché, al contrario, le vie più comode
verso la madrepatria passavano per le valli, non attraverso i monti, che,
insomma, come si dice: avevano fatto male i conti, che li avevano fatti senza
l’oste. In questo caso l’oste dovevano essere i partigiani. Invece, altro
che conti! Li avevano fatti bene, ma solo fino al momento di pagare lo scotto.
Andiamo
con ordine. A metà strada tra Arzignano e Montorso, si stacca una strada che
conduce alla Guaina appunto. A me, a Luciano, il mio compagno di
“imboscamento” dell’inverno passato, se si può dire così, e a
Costantino, viene affidato il compito di un rigido piantonamento della strada di
accesso alla Guaina; tutti gli altri, una cinquantina di partigiani dei
distaccamenti di Campofontana e di altre località, s’incamminano con tutte le
cautele verso la postazione dei tedeschi. Dopo un paio d’ore di snervante
attesa da parte di tutti noi, di noi tre in particolare, che non potevamo né
vedere né sentire cosa stava succedendo lassù sulla collina, attesa che,
probabilmente, si può solo addebitare ai movimenti di avvicinamento e di
accerchiamento della villa-bunker, sentimmo due fucilate secche, agghiaccianti,
distaccate l’una dall’altra di qualche minuto, e poi un silenzio
incredibile, pure quello di qualche minuto. Non un grido, non un segno di
smarrimento, non un indizio di disgrazia per il momento, perché tra noi tre e i
reparti operanti c’era una montagna di mezzo con tutte le sue componenti
orografiche e naturali.
Poi, di lì a qualche momento, una rabbiosa sparatoria, urla altissime di smarrimento e insieme di trionfo. Poi passano in fretta e furia, nel silenzio più ossessionante, due barelle, confezionate alla spicciolata sul posto con rami di albero e frasche di un verde lussureggiante che contrastava maledettamente con le vittime che vi erano adagiate sopra.
Seguono gruppi di partigiani che accompagnano i due malcapitati dalla sorte, e
quasi subito dopo una trentina di “SS”, con le braccia legate dietro la
schiena, disgustosi da vedersi, e altri partigiani che li sorvegliano.
Tutto
era finito così; ma intanto i nostri due compaesani, Marcello e Gregorio, erano
passati nell’al di là senza salutarci, senza incaricare qualcuno di salutare
le famiglie, senza mostrare un sorriso di compiacimento per quello che avevano
fatto, per quello che avevano contribuito a fare. Colpiti da una pallottola, di
quei fucili di precisione, qui sulla fronte, appena sopra gli occhi: s’erano
alzati sull’argine, su quel terrapieno che abbiamo citato dianzi, solo quel
tanto da poter prendere la mira. Una pallottola gli ha bloccato il dito sul
grilletto, a tutti e due. Poi i funerali, poi la memoria, poi il
saluto di noi tutti.

Nella Foto: I familiari delle due vittime
accanto alla tomba dei propri cari.
E quelli delle “SS”? Furono portati in prigione ad Arzignano e andammo a guardare anche noi le loro facce.
Là
dietro le sbarre, i loro occhi erano molto più buoni. Le loro labbra si
atteggiavano a un sorriso. Troppo tardi forse. Non so che fine abbiano fatto. A
me è bastato poter intravedere nei loro sguardi un invito all’indulgenza e
forse alla generosità.
Dopo un paio di giorni tornammo ancora in Val del Chiampo e questa volta proprio
a Chiampo e dintorni, perché ci era stato segnalato il passaggio di una
ennesima colonna di tedeschi che tentavano il rientro in Germania passando lungo
la vallata, diretti a Crespadoro, Campodalbero, Monte Marana e Recoaro.
Marciavano a gruppetti. Tattica sbagliata, adesso che ci penso e a cose fatte;
ma allora forse era la scelta migliore per tentar di sfuggire al controllo e ai
punti di controllo. Chissà perché avevano scelto questo strano modo di
fuggire. Ritenevo che sarebbero stati molto più sicuri se avessero fatto
quadrato, un po’ come avevano fatto qualche giorno prima quelli delle “SS”
con le amare conseguenze che avevano provocato. Subito dopo capimmo la ragione
di quel contegno che non aveva nulla a che fare con la strategia. Avevano gli
zaini pieni di soldi italiani; di quelle carte da mille lire che molti
ricorderanno ancora. A chili. Avevano gettato le armi nei fossi, si erano tenuti
una pistola, ma avevano fatto bottino.
Io e Costantino — che poi sarebbe diventato mio cognato — fummo i primi ad
accorgerci che qualcosa non andava per il verso giusto, che essi avevano
escogitato qualche imbroglio per farla franca. Ne fermammo quattro che alzarono
puntualmente le mani, come agnellini, ci consegnarono le pistole e finsero di
rimettersi a camminare. Noi avevamo l’ordine di disarmare solamente.
Costantino, fiutando un comportamento ambiguo, provò ad alzare uno zaino ad uno
di loro. Leggerissimo; troppo leggero rispetto al peso del bagaglio di un
soldato e di un soldato che scappa e che tenta di arrivare a casa. Lo aperse e
vi trovò il malloppo.
Fu una fregatura per quei quattro e per altri che vennero dopo di loro. Non so
quanti sono stati fermati, ma più tardi il comandante della brigata ci confessò
che erano stati recuperati parecchi milioni e che essi sarebbero serviti a
pagare alcune spese del battaglione e a riparare alcuni danni. A ogni partigiano
che aveva sequestrato uno di quegli zaini-cassaforte regalò cinquecento lire.
Era una bella somma allora. Il valore di quelle “carte da mille”, però, durò
ben poco, soppiantato dalle “Amlire”, la moneta americana.
Un prete cimbro e un soldato tedesco, angeli incoronati
Don Domenico Mercante e Leonhard Dallasega.
«La Resistenza è stata una scelta che ha consentito posizioni molteplici, come anche la testimonianza qui riportata dimostra: dai fronti dell’eroismo a quelli della sommessa pietà. Ma ci sono momenti in cui le distinzioni si riducono a un perentorio aut-aut; o dalla parte della luce o da quella delle tenebre. Un giovane soldato tedesco, padre di quattro figli, conosce l’alternativa di quell’ora. Gli vogliono far commettere un’infamia: uccidere un prete innocente. Erompe il suo “No!”, tante volte strozzato nella gola. Egli è dall’altra parte, accanto al prete, libero nella morte eroica ».
Questa
introduzione che Antonio Collo, studioso di storia contemporanea ha reso
pubblica, comparve anonima su “L’Italia” di Torino nel giugno 1959.
È
il 27 aprile del 1945. I tedeschi sono in fuga verso il Brennero. Un colonna di
paracadutisti risale la valle del Progno - Illasi, in direzione di Passo Pertica,
nel gruppo del Carega, da cui, poi, scendendo lungo la vallata di Ronchi-Ala, si
potrà guadagnare la provinciale per il Brennero. Che voleva dire: guadagnare la
strada più sicura per tornare nella terra d'origine; riguadagnare la libertà
… dimenticare una guerra terribile.
La
colonna punta su Giazza, il paesino che chiude la lunga Val d’Illasi, dove è
parroco da un paio d’anni, don Domenico Mercante, nativo del paese. Come aveva
fatto in altre occasioni quando v’era da mettere a rischio la propria persona
per strappare alla fucilazione dei giovani, si fa incontro ai soldati per
convincerli a evitare eventuali scontri armati con i patrioti che sono appostati
sulle montagne circostanti.
Sarà
questa l’ultima volta che i parrocchiani di Giazza vedranno il loro parroco.
I
paracadutisti tedeschi, per garantirsi le spalle, lo prenderanno come ostaggio
e, fucili puntati alla schiena, lo trascineranno con loro fino a Muravalle,
vicino ad Ala, al bivio con Pilcante. Don
Domenico chiede un sorso d’acqua che gli viene negato. Poi solo il crepitio
lancinante di una mitragliatrice seppellisce nel cratere di una bomba il prete e
con lui un soldato della Werhmacht. Perché un soldato? Perché era cattolico e
s’era rifiutato di uccidere un sacerdote. Era Leonhard Dallasega, nativo di
Proves, in alta Valle di Non, il 15 ottobre 1913, sposato e padre di quattro
figli. Mentre infuriava l’odio e la vendetta, due anime si univano per
l’eternità in un atto d’amore e di ideale sublime.
Vintissète
de April: in Paradiso / se spalanca le porte! Un vento novo / el impìssa le
stéle a una a una /e mile campanili i se raduna... / Gh'è du angeli novi che
riva, insieme: / uno, italian, la tònega da prete, / l'altro, todesco, con l'elmeto
in testa... / In paradiso ancó l'è na gran festa!/ Con ale de cocal, tabar de
luna, / i è rivadi col cor pien de alegria / volando piassè alti de i confini,
/ tegnendose par man, come butini...
Questo
il sunto di un’altra notizia "giornalistica", mai pubblicata, ma
apparsa sul quotidiano "La gazzetta del Paradiso" del 27 aprile
1945. Si usa questo linguaggio, asciutto, popolare, senza retorica, lassù in
Paradiso, anche quando si tratta di registrare la venuta di due nuovi angeli.
Venivano,
quei due, tenendosi per mano, dal Trentino, e più propriamente da una buca di
una bomba d'aereo, caduta mesi prima, proprio sul bivio della strada che porta a
Ceré, in quel di San Martino, nei pressi di Ala. Venivano proprio di là, da
quella buca, dove avevano fatto amicizia, all'ultimo momento, ma solo con gli
occhi e con un lungo sospiro, un attimo prima di uno sparo. Là avevano
intonato un canto: Osanna!
E
pensare che di strada ne avevano fatta assieme! Un'intera giornata. Senza mai
parlarsi; erano su due sponde opposte. Non potevano conoscersi. Forse non
avevano avvertito che erano tutti e due credenti e che questo fatto li avrebbe
uniti eternamente in un viaggio verso il serto del martirio. Quello vestito di
nero, il prete, indubbiamente e apertamente, con la sua tonaca, legalizzava e
manifestava la sua Fede; l'altro invece, in divisa militare, agli ordini di
un'egemonia tirannica e devastante, non azzardava confessare la sua. Quelli
erano i tempi. Tempi per guardarsi da lontano. Non s'erano mai visti prima e
tutti e due disperavano, uno più dell'altro. Uno soprattutto, il prete. Fino
all'arrivo in quella buca al Bivio per Ceré.
Una
volta là dentro, all'improvviso si videro, s’intesero, si cercarono a
vicenda, uno nella mano dell'altro e, insieme, si avviarono sulla strada verso
l'eroismo. Il soldato in maniera forte come quell’altro in abito talare.
Avevano bisogno tutti e due di Cielo, di prendersi per mano, di non perdere di
vista il Cielo, perché il Cielo è lì, ma non è facile raggiungerlo da soli.
Quello sparo indicò loro la scalata più veloce e marchiò a fuoco sulla pelle,
indelebilmente, un salvacondotto per arrivare alla cima. Si diedero mano, per
arrivare insieme, per non perder tempo, per far la salita più spedita.
E
arrivarono in un giorno di festa. In Cielo è sempre festa quando arriva
qualcuno che ha scalato la via più spedita, cha ha dato il suo sangue per la
Verità, quella con la lettera maiuscola. E ne arrivano tanti, ogni giorno, di
quelli che testimoniano quaggiù la Verità con la vita. Loro l'avevano
offerta tutta; il sangue l'avevano versato tutto, fino all'ultima goccia, là in
quella buca. Lui, Leonhard, perché non aveva accettato di fucilare il suo
"compagno" di fede, il prete; l'altro, il prete, don Domenico, perché
doveva essere la vittima di un qualcosa, non si sa cosa, forse dell'odio, forse
di una convenienza, di una garanzia.
Ed
era stato portato via di violenza, un po' come fece Abramo col proprio figlio
Isacco, là sul Monte Moria, ma con ben altri propositi. Là c'era da offrire
una prova solenne di fede in Jahvè; qua, invece, il tornaconto di sacrificare
qualcuno per salvar la pelle a un gruppo di fuggiaschi. Qualcuno doveva ben
pagare il pedaggio per un ritorno incolume dei soldati alle proprie case. Chi
meglio di altri? Il prete. E chi si è rifiutato di utilizzarlo a protezione di
una fuga? Il soldato. Servirono perfettamente tutt’e due.
È
questa la fine della storia di quei due inconsapevoli eroi, uno più eroe
dell'altro,
martiri uno più dell’altro. È questa la fine di don Mercante, che doveva
arrivare in cielo per un’altra strada che non fosse quella comune che batte la
maggior parte dei mortali. Non in punta di piedi, ma accompagnato da una scorta,
come quando si muovono i grandi della terra. Non poteva don Domenico morire in
un letto; non poteva prendersi una malattia e morire in pace. Partì in cerca
della centesima pecorella. La trovò in quella buca del Bivio per Ceré.
E
questa fu pure la fine della storia semplice, quasi oscura, senza grandi
turbamenti, senza tante medaglie, del soldato Dallasega, rimasto per tanti anni
ignoto; un soldato della Werhmacht, aggregatosi a un gruppo di paracadutisti,
privi di scrupoli, per tornar anche lui nella sua Val di Non. Ebbe la fortuna di
trovar sulla sua strada un don Mercante, un prete che lo guardò negli occhi e
che, presolo per mano, lo scortò fino in cielo e fece festa con lui e con gli
angeli. Senza di lui, forse, non sarebbe stata festa piena in Paradiso, neanche
per don Mercante. Ora, là nel cratere del bivio per Ceré è rimasto sepolto
solo il triste ricordo di quella raffica di fucili.
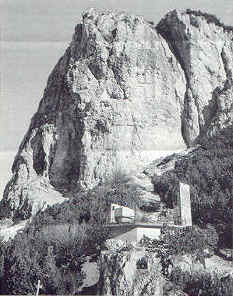
Passo Pertica
Al Passo Pertica è stato eretto un monumento in memoria dei due martiri che passarono per quella mulattiera per andar incontro al martirio. Nella cappellina di Giazza, accanto alla chiesa, don Domenico e Leonhard, uno vicino all’altro, raccontano ancora la storia dell’ultimo percorso verso la gloria.