Orlandi
Giovanni. Internato.
Nella
sua vita Giovanni Orlandi ha viaggiato molto: è stato in Libia, Grecia,
Albania, Germania, Francia, Inghilterra, Croazia e alla fine è tornato in
Italia. Questo suo andare per il mondo non è stato per divertimento, ma
trascinato dagli eventi, come succede alla brava gente che desidererebbe solo
una vita semplice e tranquilla.
Dalle
sue avventure ha guadagnato il braccio e la mano destra con la muscolatura
devastata, però la sua volontà di figlio del popolo gli ha permesso di usarli
quasi normalmente.
In
certo modo la sua storia ha le radici lontane dei poveri contadini della bassa
veronese mandati a fare carne da cannone nelle guerre. Tra di essi c’erano
anche suo zio e suo padre, che parteciparono alla “grande guerra”. I due
soldatini erano presenti al massacro di Caporetto, dove lo zio era stato anche
ferito, e avevano assistito alla feroce fucilazione dei “disertori”. Ne
erano stati così colpiti che il padre diceva sempre: “Fioi la guera l’è
bruta, bisogna starghe distanti.”
Commenta
amaramente: “Nel ’68, quando ormai i superstiti della prima guerra mondiale
erano rimasti in pochi, è stato creato l’ordine dei Cavalieri di Vittorio
Veneto, così mio padre ha avuto una medaglietta e una piccola pensione, per
fortuna lui è campato fino a 96 anni. A me, come a quasi tutti i militari
internati in Germania, malgrado gli stanziamenti tedeschi, non è stato
riconosciuto niente. Sto aspettando, non certo per i soldi, ma per avere
soddisfazione un riconoscimento. Sono ancora abbastanza giovane, di anni ne ho 85! Temo però che
aspetterò per niente, visto le risposte che mi hanno dato:
N°
pratica OIM: 1048294.
Con
la presente desideriamo informarla che L’OIM ha completato l’esame della Sua
domanda di indennizzo per lavoro forzato o lavoro in condizioni di schiavitù
nell’ambito della legge tedesca che ha istituito la Fondazione “Memoria,
Responsabilità, e Futuro”…
Il paragrafo 11, comma 3, della suddetta Legge specifica che l’ammissibilità all’indennizzo non può basarsi sullo status di Prigioniero di Guerra. Il governo tedesco ha stabilito che durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale gli IMI (internati militari italiani) avevano lo status di prigioniero di guerra…. Domanda respinta.
Però, dallo stato italiano ho ricevuto La croce al merito di guerra.

Eppure
quando eravamo nei campi di concentramento la Croce Rossa non ci ha mai inviato
pacchi perché, per quell’Ente, a differenza di inglesi, francesi, americani
ecc.. non eravamo prigionieri di guerra (1). Se podaria dir bechi e bastonà”
La
sua era una famiglia di contadini (laoranti) di Zimella il cui unico bene era la
casetta dove abitavano. Erano in nove: i genitori, tre fratelli e quattro
sorelle, Giovanni era il primogenito: classe 1921: “Mi ‘o fato el militare
par tuti, anca par i me fioi”. E’ andato a scuola fino alla quarta
elementare, a quei tempi, un grosso risultato per un contadino.
Prenderà
il diploma serale di quinta per
andare in fabbrica negli anni ‘60.
Per
una famiglia così numerosa sostenersi era difficile quindi, attraverso il
federale del paese, i genitori fecero domanda per andare in Africa a lavorare
nelle colonie.
Radunarono
le loro poche cose in qualche baule e, quando arrivò la comunicazione,
partirono per Genova dove si dovevano radunare 800 famiglie, il viaggio era
pagato.
Rimasero
in porto 15 giorni in attesa che tutti arrivassero, finalmente nell’agosto del
’38 iniziarono il viaggio. La prima tappa fu Tripoli, dove avvenne un primo
smistamento dei coloni, poi si diressero in Cirenaica aspettarono ancora un
po’ sulla nave, poi in un attendamento a Barce.
Il
motivo dell’attesa era che le case non erano ancora finite. Infine, bagagli in
spalla, arrivarono nel nuovo villaggio di Oberdan. Erano il primo gruppo di
coloni che prendeva possesso delle abitazioni: 200 villette unifamiliari ai due
lati dell’unica strada. Ogni casa era arredata in modo semplice ma completo:
lettini di ferro, tavoli, sedie, un focolare per far da mangiare, la legna la si
trovava nei dintorni.
Ad
ogni famiglia erano assegnati 30/40 ettari di terreno, le bestie e i macchinari.
Purtroppo l’ambiente non era sereno perché più di una volta i nativi
entrarono nel villaggio ferendo e uccidendo chi vi abitava. “Lori noi volea
mia che la gente andasse li’ a laorar le loro tère però loro le avevano
lasciate sempre incolte”.
Questi
fatti e lo scoppio della guerra, indussero la famiglia a decidere il ritorno in
patria: Giovanni era di leva, altrimenti avrebbe dovuto fare il militare in
Libia, la madre era preoccupata.
Così,
senza aver neppure seminato, ritornarono a casa mentre il padre restava sul
posto per guadagnare qualcosa. Di questo viaggio così penoso il nostro
protagonista ha un ricordo che oggi può far ridere ma allora….
“Io non avevo mai avuto un vestito completo e un signore, per cui
lavoravo nei campi, andò a Valdagno nel famoso lanificio Marzotto e mi acquistò
un taglio di stoffa bellissimo: era a quadretti come se usava alora. El me
piasea proprio, me parea un sogno. Non vedea l’ora de metterlo però non
gh’era tempo par farlo, se doea partir. Mia mamma disse: ”Lo faremo fare
quando ariveremo in Africa”. Ma, anche lì, tempo non ce n’era stato e la
pezza era stata reimbarcata con noi. Giunti a Genova i bauli erano stati quasi
svuotati da mani leste e il mio “vestito” era sparito. Partiti poveri e
tornati ancora con meno. Per fortuna a Zimella avevamo ancora la vecchia casa
che non era stata affittata altrimenti…
Il
10 Gennaio del ’41 andai al distretto e poi mi destinarono a Bressanone dove
rimasi fino ad Agosto. Facevo parte del 231 Fanteria, della divisione Brennero,
una divisione di fanteria motorizzata, almeno sulla carta. Questa divisione
faceva parte del IV corpo d’armata comandato dal generale Carlo Spatocco e
aveva sede a Durazzo, era inquadrata nella IX armata agli ordini del generale
Renzo Dalmazzo che dipendeva dal gruppo d’armata Est comandato dal generale
Ezio Risi.
Già
a Bressanone, mancando di graduati mi proposero di diventare caporale, ma
rifiutai, non mi piaceva comandare nessuno. Poi partimmo per la Grecia, il 231
aveva preso 2 anni di presidio ad Atene per tenere in buon ordine quel
territorio dove si era combattuto molto. La tradotta ci portò a Brindisi e di lì,
velocemente ad Atene dove scoprii che, contro la mia volontà, ero diventato un
graduato.
In
città non c’erano caserme per
cui alcuni vennero alloggiati in tende io e il mio gruppo fummo trasferiti in
una ex ghiacciaia. In questo vasto ambiente per terra c’erano dei materassi di
paglia dove si dormiva. Mangiavamo serviti dalla cucina da campo e il materiale
si trovava nella vicina fureria. Il nostro incarico era di fare la guardia ai
punti importanti della città nella
quale, però, non successe mai niente di pericoloso. Con i greci avevamo
pochissimi rapporti. Quello che era certo era che c’era una gran fame e ci si
stringeva il cuore a vedere i bambini, tutti stracciati, che venivano a chiedere
la carità di un pezzetto di pane. Oltre che all’Acropoli attraverso a dei
camminamenti arrivavamo al mare e alle colline lì attorno dove erano nascosti
dei partigiani. Qualche pattuglia si trovò a dover sparare, non la mia che fu
coinvolta solo in un conflitto a fuoco con…un ufficiale italiano.
Andò
così: era notte e ci trovavamo a sorvegliare la costa. Improvvisamente mi
sentii chiamare: “Capoposto, capoposto, qualcuno si avvicina nei camminamenti
cosa facciamo?” Svelto corsi a vedere, infatti, furtivamente, qualcuno si
muoveva nell’oscurità.
“Aspettiamo
che si avvicini”, dissi, “poi gli lanciamo un paio di bombe per farlo
scappare.”
E
così facemmo. Sentimmo un urlo: ”Fermi, fermi, sono io non sparate!” Era un
tenente che avevano degradato da capitano. Voleva venire a portare via la
mitraglia alle guardia per farsi bello con i superiori ed essere reintegrato nel
grado. Alla mattina in fureria mi rimproverò: “Non credevo che avresti fatto
così”, “Neanche io credevo che lei facesse così per farmi finire in
galera”. “Ci rivedremo a Legnago” ( tra Legnago e Zimella non corre buon
sangue) e io: “Ci troveremo là e ne parleremo”. Ma
non l’ho più visto.
Dentro
di me sentivo un po’ di entusiasmo, almeno un colpo l’avevo sparato. Dopo
questo atto fui nominato Caporal
maggiore.
Una
parte della divisione partì per l’Africa: sembrava
che dovessimo andarci anche noi, ci avevano già date le nuove divise, ma
gli inglesi cominciarono a silurare le navi e così i comandanti decisero che
saremmo restati lì. Restituimmo il corredo. Non sapevamo niente di quello che
capitava intorno a noi: non c’erano radio, non c’erano giornali così,
all’improvviso, sapemmo dell’8 settembre. Dopo i primi momenti di gioia si
cominciò a pensare a quali sarebbero state le reazioni dei tedeschi che però
erano ancora lontani.
Il
nostro colonnello decise di rientrare in Albania dove c’era il comando di
divisione e iniziò la nostra marcia a piedi verso Tirana, altro che truppe
motorizzate.. Costeggiavamo il mare su una strada che si rivelò minata dai
partigiani, infatti cominciavano a farsi vivi.
Guardando
verso i monti i nostri ufficiali si accorsero che c’erano delle mandrie di
mucche ce ne fecero catturare una grande quantità, le mettemmo a precedere la
colonna che potè continuare il viaggio. A Tirana era tutto tranquillo. Due
battaglioni si unirono alla
divisione Firenze, uno andò a combattere a Corfù.
Poi
arrivarono i tedeschi dalla Jugoslavia. Era il 24 settembre, avevamo cominciato
a sparare quando il comandante ordinò di sospendere il fuoco e di
arrenderci.”
Il
povero caporale, non capì molto; ma chi va sul sito www.anrp.it: rassegna
agosto settembre ottobre 2005 pag 6 e seguenti troverà importanti chiarimenti.
Se leggerà il libro “Lo
specchio” del tenente Enrico Ciantelli, Casa Editrice Le lettere, avrà il
racconto di un uomo che fu protagonista delle trattative tra il comando italiano
e quello tedesco e che adombra il tradimento dei suoi diretti superiori.
Giovanni
prosegue: “I tedeschi ci disarmarono portandoci via tutto, fu una cosa
umiliante e tristissima. Non ci chiesero se aderivamo o no alla repubblica di
Salò, ma ci mandarono tutti, tranne gli ufficiali, a Durazzo e ci misero su
cinque piroscafi scortati da due torpediniere e da un incrociatore. Costeggiammo
la Jugoslavia i tedeschi sparavano continuamente contro la costa e i partigiani
rispondevano: per fortuna i colpi non erano precisi. Eravamo ammassati nella
stiva e mi capitò un piccolo colpo di fortuna, scoprii una riserva di gallette
e, approfittando della disattenzione della sentinella, me ne riempii lo zaino.
Il viaggio durò una giornata e ci trovammo a Trieste.
La
nave si fermò fuori dal porto e
molti cercarono di scappare buttandosi in acqua e i tedeschi li ammazzavano a
fucilate. Restammo alla fonda tre giorni, sempre senza mangiare. Una volta
sbarcati, in mezzo a un cordone di fascisti e tedeschi che ci insultavano,
venimmo condotti alla stazione ferroviaria e ci stiparono a gruppi di quaranta
in carri bestiame. I vagoni vennero chiusi ma intorno ad essi la gente di
Trieste portandoci del cibo ci incoraggiava: “Vedarì fioi che i ve porta a
Bologna a scavar le macerie! Starete qui vicino”. Il treno partì, andava in
direzione ovest, speravamo che ci portasse verso casa. Poi si fermò a Padova.
Anche qui la gente cominciò a circondarlo: chiedevano dei loro cari e ci
portava da mangiare, era una scena piena di emozione. Ad un certo punto qualcuno
riuscì ad aprire gli ultimi vagoni per far scappare chi vi era rinchiuso e i
tedeschi si misero a mitragliare senza pietà.
Ci
furono dei feriti e dei morti anche tra i civili. Ristabilito l’ordine e
chiusi i vagoni, restammo a Padova altri tre giorni senza mangiare o bere. Io
avevo le mie scorte di gallette, ma l’acqua non c’era, avevo la gola che
bruciava. Eravamo ormai in ottobre. Poi il treno riprese la sua marcia
dirigendosi verso est. Mentre andavamo alcuni coraggiosi cercarono di scappare
togliendo le assi del pavimento e calandosi sulle rotaie ma quasi tutti furono
uccisi dalla catena del treno che
li colpiva violentemente. Ci fu un’altra tappa a Udine dove si rinnovarono le
scene di disperazione di chi chiedeva dei famigliari, mentre le donne cercavano
di portarci del cibo che i tedeschi, se potevano, buttavano via. Sempre senza
mangiare e senza bere, ormai non ne potevamo più, arrivammo a Tarvisio, qui,
sentendosi a casa loro, aprirono i vagoni e ci distribuirono una fettina di
pane, intanto cominciava fare freddo, eravamo ormai in ottobre, e noi avevamo
ancora le divise leggere.
Ripartimmo
e per arrivare a Essen, città sede della grande industria siderurgica Krupp,
impiegammo un giorno. La città era un centro di smistamento dei prigionieri. Ci
immatricolarono, ci visitarono, ci attaccarono un nastrino con l’indicazione
del posto dove eravamo assegnati e, dopo due o tre giorni, ci caricarono sui
camion e ci portarono nelle varie destinazioni. Io fui mandato a Rheinausen,
cittadina a sinistra del Reno, quasi un sobborgo industriale di Duisburg che
invece si trova a destra del fiume, ed è nodo stradale e ferroviario
importante.
Era
una enorme fabbrica della Krupp, vi entrava il ferro e uscivano i carri armati
quasi pronti. Si estendeva per 25 km quadri con migliaia di lavoratori. Nel
campo c’erano 23 capannoni ognuno ospitava 200 persone. Ogni capannone era
suddiviso in scomparti: le baracche dove ci si stava in otto, ognuna aveva la
sua stufetta a legna e la sera passava il maresciallo che con un bastoncino
frugava per vedere se c’era cenere, allora sarebbe scattata la punizione,
perché loro volevano la pulizia. Ci diedero una specie di tuta che dietro
portava una grande V iniziale della parola Verroter (traditore). Questo fu
l’unico tipo di abito che portammo.
Per
fortuna in quei due inverni, che in molte altre parti furono freddissimi, da noi
non nevicò e poi, o eravamo in fabbrica dove la temperatura era elevata, o in
baracca.
Eravamo
divisi per nazionalità e tra di noi e gli altri prigionieri c’erano dei
recinti. Non vidi mai alcun nostro ufficiale, li avevano destinati ad altri
campi. Alla mattina sveglia alle 5, appello e contrappello per essere pronti
alle 6. Poi, in fila, circondati dalle guardie andavamo alla fabbrica che era
abbastanza vicina, e ci smistavano nei vari reparti. Alla sera, sempre con le
guardie, facevamo ritorno. Così andò avanti fino all’ Agosto del ’44
quando diventammo liberi lavoratori, liberi di che, non si sa.
Dopo
di allora ci accompagnarono solo all’andata, così al ritorno qualsiasi tipo
di erba che vedevo la raccoglievo per mangiarla. Facevamo turni di dodici ore,
la fabbrica non si fermava mai. A noi italiani erano riservati i lavori più
pesanti e faticosi. Ci pagavano con due sigarette al giorno e con dei soldi loro
che si potevano spendere solo nel campo.
Inizialmente
fui assegnato alla fonderia lavoravo con una donna ucraina, una persona
dolcissima e gentile che alla mattina, quando poteva, mi allungava qualcosa da
mangiare.
Ci
parlavamo poco per via della lingua. Il nostro compito consisteva nel
raccogliere le sbarre di ferro ormai raffreddate e portarle in deposito con una
gru. Siccome nella fabbrica c’era anche uno scalo ferroviario, prima di
timbrare il cartellino me ne andavo in giro e tentavo di rubare dai vagoni
quello che potevo e lo nascondevo sotto la mia traversèta.
Per
questo presi anche delle randellate con quei loro manganelli con l’anima di
acciaio. Il mio capo che era un buon uomo, sapeva dei miei furti e mi diceva
“Joann, luki, luki” (Giovanni, stai attento) e cercava di coprirmi come
poteva. Io per tentare di sdebitarmi, anche se ero un accanito fumatore, gli
passavo le mie sigarette. Poi sentii dire che agli altiforni davano mezzo chilo
di pane e io, per la fame, chiesi di essere trasferito lì. Fu un’idea
sbagliata perché il lavoro era bestiale e i capi cattivi. C’erano otto
altiforni di provenienza americana, ciascuno di noi doveva raccogliere il
materiale con un carrello se ne sfuggiva un poco doveva raccoglierlo il più
veloce possibile perché il lavoro non poteva essere rallentato. E come si
arrabbiavano, ma le forze erano quelle che erano, ormai.
La
dieta è presto detta: la mattina un po’ di brodaglia, tipo the, a mezzogiorno
un brodino con un po’ di margarina e una fettina di pane, la sera la stessa
cosa. Alla fine ero arrivato a pesare 45 chili.
A
proposito della fame mi capitò una avventura che adesso sembra da ridere, ma
allora…
Un
giorno, eravamo nell’autunno del ’44, ero in baracca e capitò
l’interprete, un altoatesino, che cercava uno che fosse capace di tirare il
collo a un’oca per un signore che lo accompagnava. Io mi offrii subito,
speravo di ricavare qualcosa, anche se non avevo mai copà nessuno gnanca ‘na
galina...
Così,
assieme all’uomo, mi avviai verso casa sua. Strada facendo passammo attraverso
una campagna dove vidi un frutteto con tante mele cadute per terra e pensai che
al ritorno, se si fosse presentata l’occasione… Arrivato alla casa, la
padrona presentò l’oca che, non avendo mai fatto quel lavoro, come ho detto,
feci fuori con difficoltà tagliandole la testa. Tribolai anche a spennarla ma
alla fine l’avevo anche “curata” per bene.
La
padrona, soddisfatta, mi offrì un piattin
de lasagnete, ah quele lasagnete… le mangiavo e mi scendevano le
lacrime dagli occhi. Poi fece un pacchetto di testa, zampe e interiora e me lo
consegnò mi domandò se conoscevo la strada per tornare da solo: “Ma
certamente!!” Mi vedevo già in camerata a mangiare brodo e mele con i
compagni.
Ringraziai
e me ne partii veloce. Quando arrivai dove c’erano le mele, tre o quattro me
le mangiai e poi me ne riempii i calzoni che chiudevo con le fasse, e la giacca.
Ero ingrassato in modo incredibile! Sembravo la reclan delle gomme Michelin.
Purtroppo,
arrivato alla porta del campo, uno di quei ragazzini che avevano arruolato nella
milizia territoriale per fare la guardia, dato che gli uomini abili erano ormai
tutti al fronte, mi fermò: “Tu italiano, comesì, comesà” (termine che
usavano per dire: hai rubato). Io negavo ma lui mi portò dentro dal
maresciallo: “Tu italien, Badoglio, macheroni “. A quell’insulso
dell’interprete dissi:” Varda che el me li ‘a dà el paron.” E lui:
”Non è vero sei stato tu che te li sei andati a prendere nel campo”.
“Cosa te interessa a ti non son mia andà a destacarli da la pianta, i era in
tera.”
E
quello invece traduceva come voleva lui. Allora il maresciallo si mise a urlare:
“Ei comesì, comesà” mandò a prendere un cesto e mi prese tutti i pomi. E
el scartosso dell’oco l’è sta butà via.
Poi
prese uno di quei loro famosi manganelli, di cui ho gia parlato e voleva
picchiarmi.
Purtroppo
per lui, gli mancava una gamba e ci mettemmo prima a fare le finte da una parte
all’altra della tavola e poi a correre attorno ad essa fino a che riuscii a
infilare la porta e scappai via, lasciandoli con un palmo di naso. Mi cercò in
baracca e in fabbrica per quindici giorni, poi, per fortuna,
se la mise via.
Un
altro ricordo brutto, legato sempre a quel maresciallo risale al Natale del
’44. Premetto che nel cortile del nostro capannone c’erano un gran numero di
tubi di cemento armato che servivano da riparo durante i bombardamenti, se
eravamo in baracca. Quando bombardavano, ed eravamo alla fabbrica, c’era a
disposizione dei tedeschi un rifugio sotterraneo in cemento armato. Ma
difficilmente potevamo entrarci perché venivamo respinti dal solito grido:
“Nein, nein, italien, veck” Così ci riparavamo da qualche parte sperando
che andasse bene. E la fabbrica fu spesso colpita e poi subito riparata. In uno
degli ultimi attacchi aerei degli alleati, come mi disse il mio vecchio capo
delle fonderie, restò morta anche la mia amica ucraina.
Ma
torniamo a quel Natale. Nel nostro capannone alloggiava, in una stanza a parte,
l’attendente del maresciallo. Il giorno di Natale sparì una spazzola che
teneva nel suo bagno personale. Fummo tutti interrogati ma non si scoprì
l’autore del furto, che oltre a tutto sembrava impossibile. Il maresciallo,
inferocito, ci fece strisciare in cortile sui gomiti e le ginocchia, per cinque
ore obbligandoci a passar sopra a quei dannati tubi infinite volte.
C’è
da meravigliarsi se alla fine eravamo ridotti quasi all’estremo. Nel nostro
campo, però, a differenza di altri, avevamo un’infermeria con un ufficiale
medico tedesco e le cure non mancavano, se la malattia non era la fame di cui
morì un mio compagno di baracca. I compagni ti dicevano: “Stai attento a non
diventare più magro perché ti mandano ai forni crematori.”
Che
in quel campo essi ci fossero non lo posso dire, ma che si sapesse della loro
esistenza da qualche parte, lo posso confermare. In infermeria fui ricoverato
per un po’ di tempo e curato con il chinino, perché in Albania avevo preso la
malaria che mi procurava degli attacchi di febbre spaventosi.
Nel
Marzo del ’45 ormai gli americani stavano arrivando sul Reno e, oltre ai
soliti bombardamenti, erano continui colpi di granate e bazooka. I tedeschi ci
incolonnarono tutti e ci portarono in aperta campagna, ci rinchiusero, senza
cibo e acqua in un grande ambiente sotterraneo, eravamo in circa 400, non ci si
poteva quasi muovere. Intorno era scoppiato l’inferno. Cercavamo di spaccare
la porta per scappare ma era impossibile, non avevamo nessun attrezzo. Ad un
certo punto un mio compagno ebbe l’idea di andare a sedersi sotto una
finestrella che c’era e poco dopo da essa entrò un colpo di granata. Fu una
carneficina Mi sentii un fuoco al
braccio destro il mio amico mi tirò su la manica e disse: “Sei stato
ferito”.
Subito
staccò un pezzo di camicia e mi legò il braccio sotto la ferita e sopra fece
un laccio con il cordino dello zainetto. Intorno c’era chi gridava, chi non
parlava più, una scena spaventosa. Decidemmo, vista la breccia nella finestra,
di andarcene prima che arrivassero altri colpi. Eravamo in campagna ma anche le
poche case erano ridotte a muretti bassi dai bombardamenti.
Pensammo
di rifugiarci scendendo una scaletta in una cantina: “Fermemose qua, vardemo
se viene qualcuno”. Ma c’erano dei tedeschi: “Nein, italiani, Badoglio.”
Riprendemmo la ricerca di un qualche rifugio, lui mi teneva lo zainetto perché
io non ce la facevo proprio.
Alla
fine trovammo un’altra cantina, questa volta vuota, e ci nascondemmo:
“Speremo che i vegna i americani”. Rimanemmo lì senza muoverci due giorni
mangiando rape rosse crude, senza acqua. Una sete... la bocca incolà.
Una
mattina il mio amico decise di uscire all’aperto, si sentiva del
movimento e sirene che suonavano. Mi chiese: “ Gheto le pesse da piè?.” Le
avevo nello zainetto. “Perché?” “Le taco fora e se i passa e i vede
qualche bandiereta, i se fermarà.” Arrivarono infatti ed erano negri, i primi
che vedevo. Chiamarono un’autoambulanza e con una barella, testa in giù e
gambe in sù mi portarono fuori.
Poi
cominciò una storia nuova, un esempio di malasanità internazionale. Non so
perché ma la mia prima tappa fu un ospedale militare in Francia. Mi toccarono
qua e là il braccio che era nero, mi fecero tre o quattro punture sul collo e
mi mandarono in un altro ospedale militare, questa volta in Inghilterra. Qui,
dopo avermi fatto un po’ di tagli per scaricare l’infezione, mi misero delle
garze e un gesso. Loro avevano anche l’idea di tagliarmi il braccio ma io
dissi: “Spetèmo”.
Poi
arrivarono quelli della Croce Rossa che mi informarono: “ Ti rimpatriamo.”
Io mi vedevo finalmente in Italia, niente affatto, mi ritrovai in Germania. La
ferita non faceva più male ma puzzava in modo orribile: era l’infezione che
lavorava. Non mi facevano niente, non avevo più vestiti, ma una specie di
pigiama e gli zoccoli di legno e … giravo per l’ospedale
cercando degli italiani, ma dei miei connazionali non ce n’era nessuno. Poi
arrivò di nuovo la Croce Rossa mi portarono alla stazione e di lì mi spedirono
a Peschiera. Finalmente in Italia.
Il
mio vagare per ospedali stranieri era durato tre mesi. Ma non tutto il male vien
per nuocere perché, con l’arrivo delle truppe alleate e l’abbondanza del
cibo, molti miei compagni di prigionia erano morti a forza di mangiare: il loro
intestino ormai logoro era scoppiato. Io invece con la dieta ospedaliera, un
bocconcino di questo, un bocconcino di quello, me l’ero cavata bene. A
Peschiera c’erano le autoambulanze già pronte per smistare i feriti e io fui
mandato a Niguarda dove restai quattro mesi.
E
finalmente qualcuno capì quello che aveva il mio povero braccio. Il primario mi
fece togliere il gesso e mi fece operare e si scoprì che avevo in corpo una
bella scheggia di granata.
Puliamo
qui, puliamo là, mi fecero una plastica con un muscolo del costato che la prima
volta non riuscì. Assistetti sveglio alle operazioni, non avevo paura e le
esperienze mi avevano reso diffidente. Dopo un mese stavo bene, ma la mano era
tutta contorta, tanto che, per avvisare i miei che ero vivo, non avevano mie
notizie da marzo, avevo fatto scrivere a casa da un’infermiera.
Così,
un bel giorno, comparve mio fratello: erano cinque anni non vedevo nessuno dei
miei. Veniva dall’Istria, ma questa la racconto dopo.
Il
primario aveva scoperto che era stato menomato il nervo Radiale e aveva deciso
che dopo 5 mesi di convalescenza mi avrebbe operato la mano per farla stare tesa
ma rendendola del tutto rigida.
Quando
mi dimisero dall’ospedale andai dai miei in Croazia: nella casa di Zimella
c’erano degli inquilini.
Ma
come erano finiti in quella regione? Nel 1942 un ingegnere triestino che
conosceva mio padre, lo aveva messo a contatto con un gruppo di latifondisti della sua città che avevano deciso di
far coltivare a mezzadria le loro terre istriane. Avevano fatto costruire le
case, comprato sementi, macchine, bestiame. Una storia molto simile a quella che
la mia famiglia aveva vissuto in Cirenaica, ma lì erano in Italia e si
ritenevano sicuri. Affittata la casa, erano partiti in camion e per andare
a Cittanova (ora Novigrad). Erano otto famiglie, il terreno era buono, il
prodotto abbondante. Un fiumicello risaliva verso l’interno, venivano i
barconi da Trieste a comperare la verdura. Durante la guerra se l’erano
passata bene.
Immaginate
le feste al mio arrivo, la gioia di mia mamma, eravamo di nuovo tutti insieme.
A fare niente mi annoiavo cosi presi in mano il versòr (l’aratro) e cominciai a lavorare nei campi. La mano storta, con un po’ di abitudine, non mi impediva di fare la mia parte e decisi che il professore mi avrebbe aspettato per niente, sotto i ferri non ci sarei andato più. Rimasi lì, mi ambientai e conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie: una istriana purosangue, discendente dai coloni veneziani dei secoli scorsi, e mi sposai.
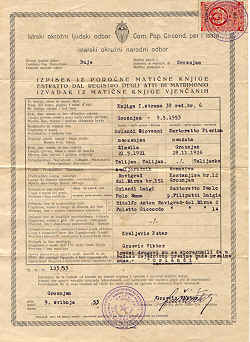
Estratto dal registro atti matrimonio
Ma la politica era
in agguato. Dal ‘47 l’Istria era diventata praticamente tutta della
Jugoslavia e i terreni dei triestini ora appartenevano allo stato che si sbarazzò
velocemente di quei mezzadri rimandandoli in Italia senza niente, anzi con un
manzo che fu venduto a Trieste.
Sulle
prime la famiglia fu ospitata in un campo profughi, c’erano delle promesse di
avere un lavoro a qualche altro beneficio in futuro, ma il tempo passava… Così
mio padre pensando che un tetto nostro al paese lo avevamo, decise di tornare a
Zimella.
Dovevano
ripartire un’altra volta da zero. Mia sorella aveva sposato un Istriano ed era
rimasta in Istria, così anni fa sono tornato in quelle terre che erano state
fiorenti e prospere e tutto è incolto e andato in rovina.
Io rimasi laggiù per più tempo: mia moglie non voleva andarsene, era nella sua patria e avevamo già tre figli. Visto che ero mutilato e reduce, mi recai a Fiume per chiedere una pensione che mi fu rifiutata: non ero un partigiano. Mi consigliai con mia moglie e decisi di riprovarci in l’Italia.
Facemmo un passaporto famigliare e partii lasciandola a casa con i bambini. Non fu un’impresa facile. Prima mi concessero una piccola pensione che sarebbe durata due anni, poi dopo una serie di peripezie con la burocrazia, mi diedero qualcosa di più dignitoso. Era arrivato il momento di far venire qui la famiglia ma prima volevo che mia moglie vedesse come mi ero sistemato: una casetta di quelle vecchie con le arèle de sora e il pavimento di nuda terra. Sarebbe venuta giù con i figli e, se la sistemazione le fosse andate bene, me li avrebbe lasciati per andare a prendere le nostre cose.

E
allora le capitò un’avventura, che adesso può far ridere, ma per chi l’ha
conosciuta suscita tenerezza e pena. Lei arrivò, la sistemazione le piacque e
ripartì per l’Istria. Verso mezzanotte un violento bussare alla porta: la
polizia. Cosa succede? “Una donna ha passato il confine con due bambini, al
ritorno non li aveva più. Si trova in carcere in Jugoslavia.”
Povera la mia moglie!! “I
bambini? Eccolì qua.”
Dopo
4 mesi mi raggiunse. Per qualche anno per lei fu duro ambientarsi. Era partita
da un luogo sul mare, aveva lasciato le sua vecchia casa e i compaesani che
erano come una famiglia. Era arrivata in un chiuso e nebbioso paese della bassa
veronese. Padrona di casa in Istria, “sposa” sotto la suocera in Italia. Io
c’ero poco in casa perché non conoscevo orario di riposo, né sabati, né
domeniche e poi chi comandava su tutti era mio padre. Ma era una donna
fortissima e coraggiosa e superò tutto.
Con
l’arrivo di mia moglie terminarono, in un certo senso, le mie tribolazioni.
Dopo è stato lavoro, lavoro, lavoro. Sono stato in campagna per molto tempo con
un buon di padrone che mi diceva: “Se i bambini hanno fame prendi un sacco di
polenta o di farina.” Poi sono venuto ad abitare a San Martino e anche qui ho
trovato una brava persona che mi ha assunto, anche se ero invalido, e mi ha
sempre trattato bene offrendomi tutte le occasioni per stare meglio e dare una
buona posizione ai miei figli, che
io chiamo il giardino d’Europa. Ho
lavorato fino all’81.”
marzo
2006 - a
cura di A. Solati
1
Leggere le varie memorie di prigionieri e La Bolgia dei vivi del nostro
concittadino Agenore Bertagna.